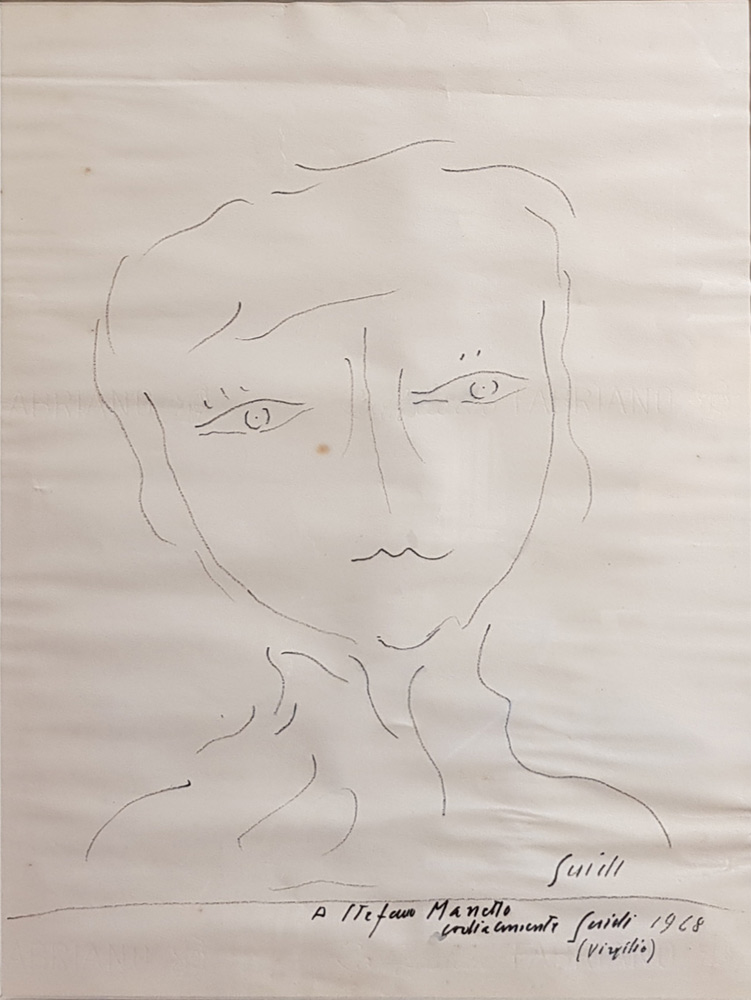Biagio Mercadante, Torraca
Autore:MERCADANTE BIAGIO
N. - M. :Torraca, 1892 - 1971
Tecnica:Olio su tavola
Misure:33 x 28 cm
Classificazione: Paesaggi, Figurativi, Oli, Antichi, Classici
Note Critico - Biografiche
Biagio Mercadante
Torraca, 1892 – 1971
Torraca

BIAGIO MERCADANTE, CENNI BIOGRAFICI
Biagio Mercadante partecipa a varie mostre nazionali sin dal 1920. In questi anni stabilisce un sodalizio con Striccoli, Ciardo, Uva, Lalli, Bresciani, Puchetti ed altri. Con loro crea il villaggio artistico Quartiere Latino nella zona di Porta Capuana e organizza varie mostre. Oltre che in Italia, espone anche a Santiago del Cile, Londra, Stoccolma, Tokio, Barcellona, Hannover, ecc. Mercadante si è affermato con una pittura che solo episodicamente sembra adeguarsi alla moda del Novecento, ma che nei suoi valori essenziali è ancora erede della tradizione ottocentesca napoletana. Questa viene da lui recuperata con consapevolezza, ma anche con un deliberato proposito di rinnovamento nell’uso della pennellata leggera ed evidente e nella ricerca di gamme cromatiche chiare ed insieme di valori tonali e luministici indagati fino al virtuosismo: particolari sono i suoi bianchi e i suoi neri resi nella loro intensità e modulazione come dei veri e propri colori. La sua propensione naturale si esprime in soggetti lirici ed intimisti; tuttavia, man mano che crescono i suoi legami con le organizzazioni fasciste, non riesce a sottrarsi alla tentazione delle tematiche retoriche dell’ideologia del regime, anche per il miraggio delle committenze pubbliche e dei premi. Nel 1964 è nominato socio dell’Accademia Tiberina di Roma. Con l’uscita nel 1987 della seconda monografia (la prima è del 1972 a cura di Alfredo Schettini) a cura di P. Burali d’Arezzo, si tenne una retrospettiva a Milano, presso il Centro d’arte Cultura e Costume.
BIAGIO MERCADANTE E IL QUARTIERE LATINO
Con la fama esigua di pittore solitario e schivo, Biagio Mercadante si spense all’età di settantotto anni, essendo nato nel 1893. Ma il velo cinereo dell’oblio non cadrà sulla sua opera, la quale – come tutta l’arte vissuta, sofferta e goduta con sincerità e amore – non sarà dimenticata.
I dati biografici di Biagio Mercadante, e il curriculum della sua vita d’artista, sono molto scarsi: egli non ebbe una vita avventurosa, movimentata o ricca di episodi, di viaggi in Italia o in altre parti del mondo. La sua arte si può dire caratterizzata da una evoluzione semplice e costante, che riflette il viso delle cose attraverso una pittura che scende dall’occhio giù nell’anima. Ed è proprio in virtù di tale consistenza che l’opera sua permane nella nostra memoria con immagini che, libere da complicanze intellettualistiche, trovano origini in una tradizione d’arte concreta ricca di comunicativa e vòlta a quella visione lirica del « vero » che fu l’immenso modello naturale per tutti coloro che, con la loro immaginazione, hanno realizzato le opere più belle della pittura moderna.
Nato a Torraca, nel Cilento, Biagio Mercadante non fu come tanti provinciali i quali, una volta respirata l’aria dei grandi centri d’arte e di cultura, dimenticarono il paese d’origine e si affrettarono a snobbare il meglio della tradizione che li aveva fatti artisti. Quanto lontano, Mercadante, da simili insulsi atteggiamenti estetici o politici, che non potevano certo essergli congeniali!
Egli amava la sua terra, la sua gente e la collina che dall’alto dominava il mare di Policastro. E, fin dall’infanzia felice, amò la pittura che rifletteva la vita di quel paesaggio natio, la sua bellezza, la gente dei campi: anche se, coi passar del tempo, la gioia di vivere in quell’ambiente si era tramutata in uno stato angoscioso, dopo le distruzioni della seconda guerra mondiale e poi per l’incombere dell’altra minaccia, non meno grave, rappresentata dalla speculazione edilizia. Già in un suo scritto aveva parlato della tradizione dei « Cordici » che andava lentamente spegnendosi: l’ascensione dei pellegrini sull’ameno colle registrava ogni anno una sempre minore affluenza, anche se forse la fede era ancor viva nei cuori. E ciò che più lo angustiava era quel lento scomparire della vita georgica, il diradarsi delle millenarie pastorizie e la graduale, inarrestabile sparizione delle stradette, dei vicoli, delle case di contadini sparse sul pendio, quasi nascosto nel verde.
Ai piedi dei « Cordici », nella storica e laboriosa cittadina di Sapri protesa sull’azzurro mare, Biagio Mercadante (dopo che l’appartamento di Napoli fu danneggiato dai bombardamenti) allestì lo studio con annesso deposito di centinaia di opere finite o rimaste abbozzate. Non voleva ingombri nel luogo ove lavorava: la tela sul cavalletto era sempre l’ultima che dipingeva, a lato della modella in posa sullo sfondo delle pareti chiare e disadorne.
A dodici anni, col manifestarsi della vocazione artistica, fu iscritto all’Istituto di Belle Arti di Napoli, ove nel 1902 Vincenzo Volpe aveva sostituito il suo maestro Domenico Morelli alla cattedra di pittura. La scomparsa di Morelli (preceduta da quella di Palizzi, di Toma e di Stanislao Lista, autentici apostoli dell’insegnamento) segnò per l’Istituto di via Costantinopoli al fine di un lungo periodo di splendore che aveva posto Napoli all’avanguardia delle scuole di pittura, come fu storicamente documentato in occasione della prima Esposizione di Firenze del 1862.
In quei primi anni del Novecento, l’arte più viva che si faceva a Napoli era ancora quella dei superstiti maestri della grande scuola del secolo precedente, comprendente gli artisti della generazione di Michetti, Mancini, Migliaio, Caprile, Pratella, coevi di Salvatore Postiglione, Irolli, Casciano, Scoppetta; fra gli scultori, in prima linea erano Gemito, D’Orsi, Cifariello, Giuseppe Renda. Seguì poi la fiorita artistica dei più giovani, nati tra il ’70 e 1’ 80: Luca Postiglione, Carlo Siviero, Ricchizzi, Viti, Villani, Galante, primeggianti insieme agli scultori Giovanni de Martirio e Saverio Gatto (questi ultimi usciti dallo studio di D’Orsi). Dopo la scomparsa dei due grandi innovatori Morelli e Palizzi, con Cammarano fu istituita la scuola serale del Nudo a bianco e nero, che poteva essere frequentata anche da alunni esterni. Da Michele Cammarano, formidabile interprete della realtà e della natura, i giovani del tempo (da Siviero a Ricchizzi, da Viti a Villani) impararono a costruire la figura umana, a rendere l’anatomia degli alberi, a modellare le rocce e le montagne stagliate su cieli martellati d’azzurro; appresero altresì la legge dei contrasti, la saldezza del tono – luce, la natura specifica di un elemento: stoffa o pietra, albero o terreno. Fra gli ultimi allievi, frequentarono la sua scuola di nudo Crisconio e Mercadante, prima che l’ottantenne glorioso maestro abbandonasse l’insegnamento, indignato dalla irriverente condotta di alcuni allievi.
Biagio Mercadante intuiva che la vocazione artistica era condizionata alla buona volontà di studiare e, soprattutto, al rispetto per i maestri che – come il Cammarano – rappresentavano la parte vitale della tradizione, dalla quale prendeva fisionomia l’opera d’arte, pur recando l’impronta personale dell’artista. È sempre una gioia degli occhi e un godimento dello spirito trovarsi alla presenza di una bella pittura: il piacere diventa intenso se si può gustare la ricchezza della materia, la sostanza del tessuto di una superficie, lo spirito di una pennellata e, insomma, attraverso tutte codeste doti di resa, parlare direttamente con l’artista che diede forma e sentimento all’opera. E Biagio Mercadante (che non aveva potuto giovarsi della guida di Lista e di Toma) parlava con entusiasmo di quel poco che aveva potuto apprendere da Cammarano.
Per le prime esercitazioni, il maestro suggeriva lo studio dei bianchi e dei neri: non che questi offrissero difficoltà facilmente superabili, ma perché conducevano, non importava se per vie faticose, alla conquista delle vibrazioni più imponderabili del colore e a sviluppare la sensibilità dei mezzi toni. Tutte le modulazioni intorno a un bianco dipendono da esso, in esso sono riflesse: un bianco pone la scala cromatica nel giusto registro dei valori, a condizione che perda la qualità sorda della materia e diventi esso stesso colore. E così il nero: può giungere alle più profonde espressioni e può diventare il più sottile o canoro strumento (come quello del diabolico Paganini) e svolgere, intrecciare, modulare e rendere le più ricche variazioni della tavolozza. Il nero sarà sempre apprezzato, e i veri pittori non se ne staccano, anche se nei primi tempi possano giudicarlo ingombrante e fastidioso. Per tal motivo Mercadante (e con lui Crisconio, Striccoli, Viti) furono affascinati, oltre che dal nero di Cammarano, dai neri di Morelli e di Mancini, come si può giudicare da certi loro ritratti e mezzefigure.
Intorno agli anni Venti, subito dopo il primo conflitto mondiale, incontravo sovente Biagio Mercadante: io frequentavo il suo studio al Rettifilo (ove aveva anche l’abitazione), ed egli veniva a trovarmi nel Brio studio, a Villa Lucia. Ebbi modo, così, di seguire i suoi sviluppi, che si realizzavano in quell’ambiente domestico nel quale si coltivava la musica e il canto: e c’era quasi una sincronia tra le sue pennellate e le note delle opere di Verdi, di Donizetti o di Puccini.
Nel 1920 partecipammo entrambi per la prima volta a un’importante rassegna: l’Esposizione d’Arte Giovanile Napoletana, allestita nella Galleria Principe di Napoli. La giuria aveva accettato i nostri lavori, ma il pensiero di dovere affrontare il giudizio della critica e del pubblico ci teneva in grande ansia. Ricordo peraltro la favorevole accoglienza riservata ai tre dipinti di Mercadante: Angolo di Napoli, Barche e Ritratto di uno scultore i quali, nel contesto di tutte le altre opere di pittura e di scultura – comprese quelle dei maestri, che di buon grado avevano accolto l’invito di affiancarsi ai giovani – evidenziavano, quale nota essenziale dell’uomo e dell’artista, la sincerità. (Del resto, gli artisti veri furono sempre sinceri: che anima ci può essere nell’opera d’arte se manca la sincerità?).
Nella primavera dell’anno successivo partecipò a un’altra grande collettiva, inaugurata da Vittorio Emanuele III: ed allestita alla Floridiana dalla Promotrice « Salvator Rosa », che allora non aveva ancora la sua « casa dell’arte ». (In proposito, rimase proverbiale ciò che Luca Postiglione disse in una procellosa assemblea: « Toglietevelo dalla testa! Il palazzo dell’arte non l’avremo mai, perché dimenticarono di costruirlo i Borboni! »). Il sovrano, col suo seguito di uomini in tuba e redingote, aveva da poco lasciato la villa quando, tra i quadri intonatissimi allineati sulle pareti, risuonò una nota stonata che fece trasecolare i visitatori: con, stridente verbosità polemica, un « contestatore » indirizzò una ingiuriosa protesta alla giuria di accettazione, di cui facevano parte Gemito e Casciaro. Si udirono parole fino ad allora inusitate nel vocabolario artistico: una terminologia presa confusamente a prestito dalla dialettica di certi fautori di nuove correnti estetiche, che riecheggiavano gli sproloqui delle prime battaglie futuristiche d’anteguerra.
Allora Biagio Mercadante, sgusciando tra le persone che commentavano ironicamente l’accaduto, mi prese sottobraccio e uscimmo a respirare l’aria frizzante della primavera. Percorrendo lentamente i viali fiancheggiati da aiuole fiorite, ci avviammo verso il bianco tempietto di Venere, a picco sul ciglio della montagna di tufo, ciascuno ruminando i propri pensieri. Ci sedemmo su un sedile di pietra, lasciato appena libero da una coppia di innamorati. Biagio accese una sigaretta ed io caricai la mia pipa. Poi egli sbottò, con la sua voce asciutta di artista non chiacchierone ma ponderato e riflessivo: « Non ne ho potuto più di udire quelle bestemmie! Ma che vogliono, quei forsennati rifiuti dell’arte? Tu ci capisci qualcosa?… ».
Ne seguì una … ortodossa conversazione sulla conoscenza tecnica, sull’efficienza che permette di realizzare una forma d’arte la quale, prescindendo dalle gratuite teorie del cosiddetto « nuovo », sarà sempre da pregiarsi come una ispirata rappresentazione intuitiva della realtà. I tentativi dei pittori « dell’avvenire » rivelano spesso una sorta d’improduttività pittorica: mancano i valori, mancano i rapporti tonali nei loro quadri sterili, dalle superfici piatte e grigie, quando non sono invece esasperatamente colorate. Si potrà dire, di questo o quel pittore dell’Ottocento, che è debole, mediocre, sentimentale, sciatto o corrivo, ma non si può tacciarlo d’improntitudine o di falsità, che sono vizi recenti. L’anima di un pittore ottocentista appare spesso simile alla fiamma ilare del focolare domestico, che mal s’accorda con le vampe chimiche su cui taluni artisti del nostro secolo mettono a bollire le loro torbide miscele, che mandano un puzzo d’inferno… Se consideriamo il cammino della nostra arte, troveremo sempre i medesimi fattori che, sotto apparenze varie e con alterne vicende, ne costituiscono l’essenza. Ciò che con parola generica chiamiamo « disegno » è in realtà un trinomio che comprende qualità lineare, qualità cromatiche e densità delle ombre del rilievo. E nel concepire la forma, non possiamo prescindere da questi presupposti del « vero » tutte le volte che alludiamo al mezzo di espressione. I passaggi semitonali consentono finezze di modellato e di colore, e rendono più acuti i caratteri della verità: quei caratteri che Mercadante seppe ottenere senza però abusarne, perché li sorvegliava con accorta tensione visiva.
Frattanto, nel 1922, nacque la prima – ed unica – Biennale d’Arte Nazionale in Palazzo Reale (un avvenimento che, a Napoli, ebbe un solo precedente: l’Esposizione del 1877). Alla grande mostra parteciparono i più noti artisti italiani: Mancini trionfò con la sua stupenda personale, trasferita l’anno successivo all’Esposizione Internazionale di Venezia. Ad onta però di quei lusinghieri inizi, la seconda Biennale di Napoli non si fece: il presidente, duca Giovane di Girasole, si dimise con tutto il comitato esecutivo a seguito di attacchi inconsulti da parte di un manipolo di artisti locali che li aveva tacciati, fra l’altro, di incompetenza. Allora uno dei consiglieri, il poeta Salvatore Di Giacomo, organizzò una retrospettiva, rimasta famosa, della pittura napoletana dell’Ottocento, per sottolineare quanto – pur attraverso gli antagonismi delle scuole – si era fatto in quel secolo per affidare l’arte alla storia.
Sulla soglia dell’esposizione, Mercadante ed io ci salutammo: il giorno dopo avrei lasciato Napoli per Milano, restando alcuni anni lontano dalla nostra città. Nel 1924, con l’incarico di corrispondente del quindicinale milanese « Le Arti plastiche » e della rivista « Varietas », mi recai a Parigi, fissando la mia dimora a Montparnasse. La città non era più quella che avevo imparato a conoscere ed amare attraverso Murger: tutta una falsa bohème di artisti stranieri carichi di dollari, di marchi, di fiorini; « La Rotonde », che in origine era stato il bistrot di Verlaine, rammodernato e ingrandito rigurgitava di strani individui che facevano cerchio intorno al giapponese Fujita e ad altri artisti alla moda; era già spenta l’eco della tragica fine di Modigliani, e il furbo e istrionico Picasso aveva trovato nella babele parigina l’ambiente più opportuno per il suo famoso « Epater les bourgeois ».
Tornato a Napoli nel ’27, vi trovai la collettività artistica operante in una nuova strutturazione: non più Società Promotrice di Belle Arti « Salvator Rosa », ma Interprovinciali e Sindacali fasciste. Eccezion fatta per il « Premio Cremona »; il cui tema doveva riferirsi alle realizzazioni del regime, per altre mostre si dipingeva e si scolpiva con libertà d’intenti e di ispirazione.
Ma la sorpresa più grande la ebbi nei pressi di Portacapuana, alla prima traversa Rosaroll, ove su un grande terrazzo dell’ultimo piano un gruppo di artisti aveva installato il proprio studio, creando una specie di villaggio artistico; detto poi « piccolo Quartiere Latino ». L’idea del « Villaggio » era venuta al pittore Giuseppe Uva, un tardo, seguace di Ruoppolo e di Belvedere, che già da tempo aveva su quel terrazzo il suo studio-abitazione e il suo pollaio. Uva convinse il proprietario a costruire – in legno e muratura – altri dieci locali, da concedere in fitto ad altrettanti pittori per dodici lire mensili. I primi occupanti furono Bresciani, Buonoconto, Vincenzo Ciardo, Ettore Lalli, Biagio Mercadante, Paolo Prisciandaro, Rispoli, Carlo Striccoli. Dopo qualche tempo Bresciani mi cedette il suo studio, adiacente a quello di Mercadante, che dava sul pianerottolo e faceva angolo col quartinostudio di Peppino Uva.
Come Ciardo ricorda in « Quasi un diario », la notizia non tardò a diffondersi per la città. Un giorno venne a trovarci Libero Lo Sardo, che fu il primo giornalista ad affrontare i sei piani, senza ascensore del casamento: l’indomani il « Roma » pubblicava in buona evidenza: « Ho scoperto il “Quartiere Latino” di Napoli… ».
Su quel terrazzo, d’estate si squagliava dal caldo, d’inverno si moriva dal freddo; quando pioveva, l’acqua scorreva da tutte le parti.
Eppure, malgrado tutto, si era spensierati e di buon umore. Nel nostro « quartiere » – che andava suscitando una crescente curiosità – organizzavamo piccole mostre personali e non mancavano gli oratori che dissertavano intorno ai vari espositori. Spesso ci allietava la presenza del poeta Pasquale Ruocco, che prendeva gusto a tratteggiare i personaggi del « Quartiere » in versi impeccabili o in una prosa brillante e colorita. E venivano anche gli « intenditori », a fiutare in quale di quegli studi ci fosse odore di futuri geni.
Peppino Uva era forse il personaggio più pittoresco: rinsecchito dagli anni e dall’accanito lavoro, era diventato tutto naso, angoli, zigomi, e per una specie di mimetismo somigliava al più vecchio dei suoi gallinacci. Tutto sbrindellato, col camice bianco chiazzato di colori, a mezzogiorno in punto usciva a dare il becchime ai suoi pennuti: li chiamava per nome ed essi gli correvano incontro. Prisciandaro era invece un personaggio tra Bergerac e il murgeriano « Marcello »: il lungo naso, il pizzetto, la pipa, il cappello a larghe tese, la cravatta nera da anarchico, dipingeva fiori ed era un tipo loquace e allegro.
Striccoli aveva anch’egli un tocco romantico: dipingeva e suonava il violino, per placare i suoi furori d’arte e d’amore per la modella, che gli posava nuda o in costume. Le sue pitture erano plasticamente sode e costruite.
Il più posato fra i componenti del « Quartiere » era Ciardo, che con Lalli divideva l’arte e l’amore per la modella. Ciardo era enorme, un pallore biondastro, gli occhi grigi inespressivi, il volto quadrato. Cifariello gli aveva appioppato il nomignolo di « Testa di vitello bollito ».
Rispoli – un pittore della categoria di Peppe Uva – aveva una particolare clientela di mercanti di esportazione. La sua pittura di scene popolari e di costumi o di figure terzine aggraziate, nude o vestite, rispecchiava pulitamente la brillantezza dei suoi abiti e del suo sorriso cordiale.
Mercadante poteva essere scambiato per un bravo borghese: abito grigio fatto su misura, sempre probo, nessuna nota stonata, i capelli tagliati a spazzola, labbra sottili talvolta abbozzanti un sorriso ironico, mai loquace né espansivo, non si impicciava degli altri quartieristi, non era curioso di quello che dipingevano, raramente li frequentava.
Insomma, era il più serio e riservato. Si chiudeva nel suo studio con la modella e lavorava con tutte le comodità. Tuttavia, il quadro da mandare a questa o a quella esposizione sindacale di Napoli o al concorso del Premio Cremona (da lui vinto due volte) si compiaceva di mostrarlo agli amici del « quartiere » che più stimava e nella sincerità del cui giudizio egli credeva: e così, ogni tanto; si brindava al suo successo con quel vinello del Cilento di cui aveva in riserva qualche bottiglia.
Nel 1938, la morte di Peppino Uva segnò anche la fine del « Quartiere Latino ». L’un dopo l’altro sloggiammo. Vi rimase solo Ettore Lalli, che la sera veniva al Circolo Artistico, ove incontrava Mercadante e gli altri amici per l’abituale partita di biliardo.
Col sopravvenire dell’ultimo conflitto, Mercadante si trasferì nel Cilento, dedicandosi al lavoro nel suo studio di Sapri.
Nell’immediato dopoguerra riprendemmo a vederci allorché un comune e grande amico, amatore d’arte, bibliofilo e collezionista di raro intuito – Biagio D’Angelo – volle tentare la rinascita della Promotrice « Salvator Rosa », il cui archivio storico e le annate dei cataloghi delle esposizioni erano andati distrutti. In tale compito volle avere accanto Biagio Mercadante, come guida e collaboratore. La prima mostra della risorta Promotrice ebbe luogo in un locale di via dei Mille. Ma ogni anno bisognava trovare un nuovo locale: e questa ricorrente difficoltà, unita alla adesione imprevedibilmente scarsa di nuovi soci, finì con lo scoraggiare il buon Biagio D’Angelo, che cedette la presidenza della società all’avvocato Gaetano Vecchione. Anche Mercadante, deluso e amareggiato, se ne tornò a lavorare nella pace del suo studio di Sapri. Frattanto, nel 1953, invitato da Carlo Siviero, aveva partecipato alla « Mostra dell’Arte nella vita del Mezzogiorno d’Italia », presentando Paesaggio autunnale e Interno rustico, acquistati poi dallo Stato. L’ultimo incontro con Biagio Mercadante avvenne qualche anno fa, in occasione di una delle mostre d’arte contemporanea al Circolo Artistico Politecnico, ov’egli espose un’opera recente. La sua volontà e la sua tenacia avevano largamente agito sullo svolgimento della sua tendenza originaria e la sua pittura, di costituzione campana, rivelava come una seconda giovinezza, riflettendo quella dote rara, e al giorno d’oggi spregiata, che in etica si chiama « modestia » e in estetica « sincerità ».
Ci appartammo in una sala, comodamente seduti su un divano, a rievocare tante cose dei nostri anni passati: sembrava un secolo! Indossava, come sempre, un vestito grigio chiaro fatto su misura, una cravatta intonata, i capelli ingrigiti tagliati a spazzola, e per la prima volta aveva inforcato gli occhiali sul viso segaligno sbarbato di fresco; fumava ora una sigaretta con filtro.
– Vieni a trovarmi a Sapri, vedrai che incanto dal mio balcone che domina il golfo! … Vieni, ti farò il ritratto che ti avevo tante volte promesso al « Quartiere Latino ».
E, fissandomi, si sorprese che mancava qualcosa di integrante della mia fisionomia: – Ma come, non fumi più la pipa?… Sai, Felice D’Angelo mi ha invogliato a fare una personale delle mie opere… Ho insistito per non farla: a che serve? Mi costerebbe una fatica enorme per selezionare il meglio… E io non so giudicare me stesso…
ALFREDO SCHETTINI, Napoli, 1971